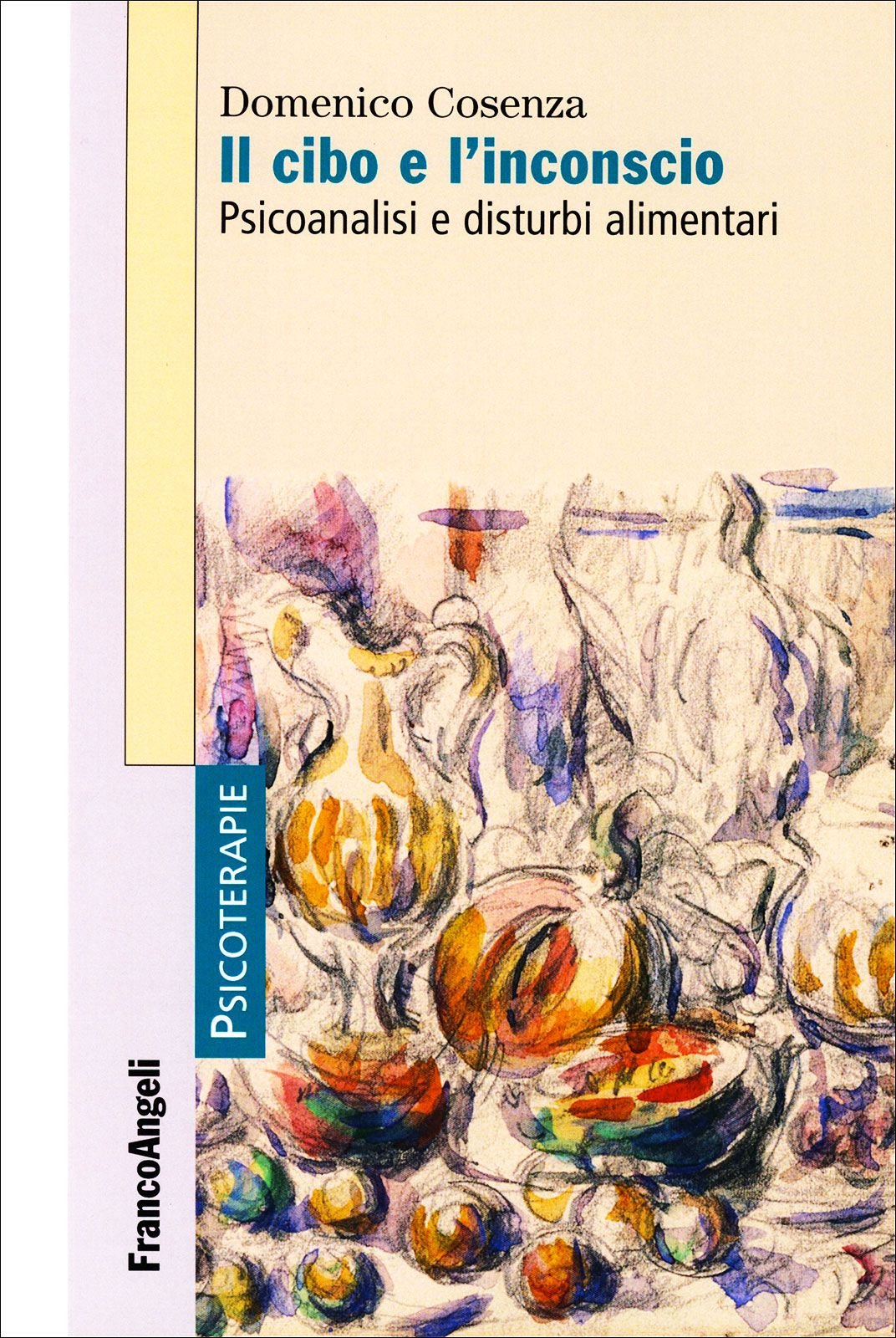IL MERICISMO
Con il termine mericismo ci si riferisce ad un comportamento ripetuto più volte nel tempo (per almeno un mese) che consiste nel masticare, deglutire gli alimenti, rigurgitarli, masticarli, deglutirli ulteriormente o sputarli. Tale comportamento è molto comune in età infantile (tra i 3 e 12 mesi) ma è una modalità transitoria e non considerata patologica, in quanto tende ad una remissione spontanea (Della Ragione, Vicini, Maria, De Santis, Chiara & Ferri, 2021).
Si tratta di un comportamento facilmente riscontrabile anche in persone affette da disabilità intellettiva e può manifestarsi in qualsiasi momento di vita. Durante il trattamento è dunque fondamentale considerare la possibilità di una duplice diagnosi, quella di ritardo mentale o di psicopatologia.
Tale pattern comportamentale è inoltre associato (in soggetti di intelligenza media) ad alcune condizioni psicologiche: stato d’ansia cronico o stato depressivo (Amarnath R.P., Abell T.L. & Malagelada J, 1986).
Per poter diagnosticare il mericismo come disturbo del comportamento alimentare è dunque fondamentale andare ad escludere qualsiasi disfunzione gastrointestinale (reflusso gastroesofageo, ernia iatale, gastroparesi etc..) la quale provocherebbe il rigurgito in modo involontario e valutare il possibile decorso di altri disturbi del comportamento alimentare, in cui la pratica del rigurgito viene attuata in modo volontario (Brega, 2016).
Proprio per questo è possibile individuare tale comportamento in chi soffre di bulimia nervosa o anoressia. In questi casi, infatti, la funzione appare autoconsolatoria e autostimolativa (Manzato, Cuzzolaro & Maria Donini, 2022).
Il rigurgito viene vissuto come modalità consolatoria in quanto il soggetto percepisce una condizione di benessere generata dalla “risposta infantile” data dal proprio corpo (Brega, 2016).
Diversi studi hanno sottolineato uno sviluppo del mericismo in soggetti che, in età infantile, hanno avuto un rapporto sano con la figura materna che è stato però interrotto bruscamente. Tale condizione ha portato ad osservare come durante l’infanzia questi bambini fossero in grado di autoprovocarsi delle contrazioni dell’epigastrio (“bocca dello stomaco”), con conseguente rigurgito del latte nella zona orale. É stato osservato che la reazione psicofisica di questi infanti, dopo il processo di rigurgito, è associabile a quella dei bambini dopo aver concluso la poppata dal seno materno. Il comportamento mericistico adottato può essere così guidato da una fantasia connessa al processo di allattamento materno. Non potendo contare sulla presenza fisica della propria figura di attaccamento, gli infanti cercano, in questo modo, di ottenere la stessa gratificazione psicofisica derivante dall’allattamento, andando a simulare l’intero processo con tutte le sensazioni ed i piaceri ad esso annesso. In questo modo negano l’assenza della figura materna diventando loro stessi tale figura mancante.
Partendo da questo presupposto, di fronte all’assenza di un legame di attaccamento sicuro in età infantile, questa forma di comportamento, in età adulta, assume una funzione difensiva. Attraverso il mericismo, la “fame d’oggetto” connessa ad una pulsione orale viene soddisfatta solo simbolicamente, impedendo la consapevolezza di un reale bisogno relazionale che porterebbe la persona a doversi scontrare con l’esperienza traumatica di un attaccamento primario, deludente e disgregante. L’individuo in questo modo, cerca inconsapevolmente di rispondere ad un bisogno relazionale rimasto insoddisfatto già a partire dall’età infantile (Barone, 2010).
Chi soffre di mericismo, spesso tende ad isolarsi perché tale comportamento viene rifiutato e considerato “ripugnante” dalla comunità di appartenenza. Questa reazione da parte della realtà circostante sottrae ulteriormente l’individuo a nuove esperienze relazionali, andando in questo modo ad intensificare il disturbo stesso (Konarski et al., 1992).
Difronte ad un quadro sintomatologico così complesso risulta dunque importante identificare e riconoscere il malessere di base che lo nutre, di modo da poter lavorare su di esso e ridurre in questo modo il sintomo stesso.
Dott.ssa Rossella Ottaviani
Bibliografia
Amarnath R.P., Abell T.L. e Malagelada J. (1986), The rumination syndrome in adults, «Annals of Internal Medicine», vol. 105, pp. 513-518.
Barone, D. (2010). Tanto ruminare per nulla. International Journal of Psychoanalysis and Education – IJPE.
Brega, I. (2016). Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: non solo anoressia e bulimia. State of Mind.
Della Ragione, L., Vicini, Maria, De Santis, Chiara & Ferri, S. (2021). I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: un’epidemia nascosta.
Manzato, E., Cuzzolaro, M. & Maria Donini, L. (2022). Hidden and Lesser-known Disordered Eating Behaviors in Medical and Psychiatric Conditions: Springer.
Konarski E.A., Favell J.E. e Favell J.E. (1992), Manual for the assessment and treatment of the behavior disorders of people with mental retardation, North Carolina, Western Carolina Center Foundation